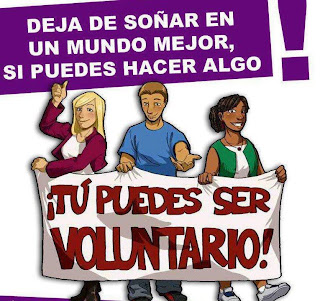Cerca nel blog
Ains è una Organizzazione di Volontariato che da diversi anni finanzia e realizza in Guatemala microprogetti sociali, scolastici, edili e sanitari.
Post
Visualizzazione dei post da luglio, 2013
Il lavoro di una donna. La realtà distorta di una giornalista freelance in Siria
- Ottieni link
- X
- Altre app
Freelance italiani di guerra. La testimonianza di Barbara Schiavulli
- Ottieni link
- X
- Altre app
Il razzismo di Calderoli e la figlia del ministro....Lettera alla Provincia Pavese
- Ottieni link
- X
- Altre app
Caffè, un fungo minaccia la coltivazione
- Ottieni link
- X
- Altre app
Il non profit cresce e fa crescere. Ma la politica spreca un’occasione
- Ottieni link
- X
- Altre app
Presentazione del progetto “Comedor Infantil”
- Ottieni link
- X
- Altre app